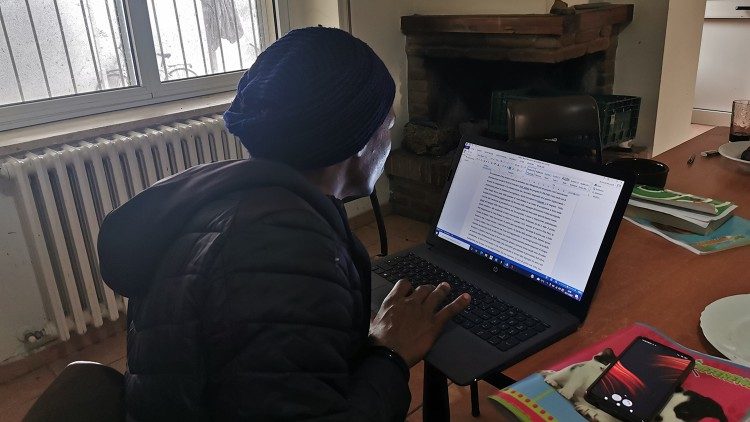A Matera dignità e futuro passano attraverso la terra
Cecilia Seppia – Città del Vaticano
Classe 1975, don Antonio Polidoro, originario di Matera, è cresciuto tra quei “Sassi”, risalenti al Paleolitico, poi fondamenta del cristianesimo, che l’Unesco ha voluto dichiarare Patrimonio dell’Umanità. Sacerdote dal 2001, direttore della Caritas diocesana, delegato episcopale per la Pastorale Sociale, il Lavoro, la Giustizia e la Pace, la Custodia del Creato, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei Migrantes e oggi anche di Casa Betania, in realtà don Antonio è soprattutto un pastore con l’odore del gregge addosso. Uno che si china sugli altri, che li guarda dal basso con l’unico scopo di rialzarli, che si rimbocca le maniche perché a nessuno manchino pane e dignità. L’accoglienza ce l’ha nel sangue, e da anni è impegnato nel combattere la piaga del coporalato, dello sfruttamento, dell’emarginazione che colpisce soprattutto i profughi, i migranti, chiunque scappi dalle proprie terre, in cerca di futuro.
Lo schiaffo del dolore e la missione
“Sono sempre stato sensibile al fenomeno migratorio - racconta il sacerdote a Pope e a L’Osservatore Romano -. Ogni volta che sentivo una notizia sugli sbarchi finiti male avvertivo nel cuore il dolore per tutte queste morti in mare e provavo a fare mio, come potevo il grido di Papa Francesco. Lo schiaffo peggiore l’ho ricevuto quando ho visto la foto di Aylan, il piccolo profugo siriano di due anni, annegato nell’ottobre del 2015 davanti alla spiaggia di Bodrum, paradiso turistico della Turchia”. In effetti ci vuole coraggio a dimenticarsi di Aylan. A faccia in giù, appena lambito dall’acqua, le braccia abbandonate, immobile nella morte coi pantaloncini blu, la magliettina rossa, le scarpe ancora ai piedi, ribalzando dalle tv ai social, è diventato simbolo della tragedia dei migranti e della decisione dei media di guardarla in faccia, senza sensazionalismo, ma anche senza ipocrisia. “Quel giorno mi è scattato dentro qualcosa - prosegue don Antonio -, quell’immagine non mi faceva dormire. L’altra motivazione forte che mi ha condotto su questa strada è stato vedere l’orrore in cui la gente viveva in questo ghetto poco distante da casa mia, a Serra Marina: degrado, abbandono, sporcizia, l’annientamento di ogni dignità umana. Sono entrato lì con un furgone carico di generi di prima necessità e ammetto di aver avuto all’inizio anche paura: c’erano più di 500 persone, senza nessun tipo di servizio igienico, con ragazze giovanissime costrette alla prostituzione, gli uomini che andavano a lavorare anche 12 ore al giorno per pochissimi euro, era uno scenario disumano. Ma dopo lo sgomento ha prevalso il desiderio di aiutarli: da qui è nata Casa Betania e anche il Centro San Giulio che è più specifico per donne e bambini. Non è stato semplice ma con l’aiuto di tutti ce l’abbiamo fatta e ora sono io che ringrazio questi nostri amici per quello che mi hanno dato in termini di ricchezza culturale, di affetto, di benevolenza. Non potrò mai dimenticare anche il momento dello sgombero del ghetto da parte delle forze dell’ordine. Io ero lì con assistenti sociali e operatori perché volevo innanzitutto portare via le ragazze con i bambini e offrire loro un posto sicuro dove stare. Ho cercato di convincere gli agenti e quando mi è stato accordato il permesso, una di loro si è avvicinata, non capivo nemmeno quello che diceva ma mi ha abbracciato ed è scoppiata a piangere in un pianto dirotto”.
Il miracolo di Casa Betania
Serra Marina fa parte del comune di Bernalda, in provincia di Matera. E’ qui che sorge Casa Betania, la “Casa della Dignità”, una struttura acquistata dalla diocesi con i fondi dell' 8xmille Cei tramite la Caritas Italiana per offrire un alloggio dignitoso ai lavoratori stagionali. “Questa casa - spiega don Antonio Polidoro - è stata pensata e ristrutturata per essere il più possibile confortevole con stanze dotate di bagni, spazi condivisi come la cucina e il soggiorno e anche aule dove favorire la formazione e l’integrazione con materiali di supporto tecnico. Ovviamente non poteva mancare un luogo di raccoglimento e preghiera per i cristiani e anche per i musulmani. La maggior parte delle persone che arriva da noi è infatti di fede islamica. Tutto intorno alla casa c’è un giardino con degli angoli coltivati ad orto. Qui, temporaneamente vivono tutti coloro che la società scarta, rifiuta mette ai margini, sono per lo più migranti senza documenti, senza un tetto, senza un lavoro: il nostro compito è in primis quello di accoglierli, non considerandoli come numeri ma come persone e dargli un alloggio, perché senza un tetto sulla testa non si vive. Il secondo step su cui lavoriamo è l’integrazione. In genere nel giro di un anno riusciamo a renderli autonomi, abbiamo fatto delle convenzioni con diversi enti, aziende agricole e imprenditori che attraverso tirocini riescono ad inserirli regolarmente nel mondo del lavoro. Con i documenti in regola e un impiego, queste persone riescono a prendersi un appartamento in affitto e a guardare al futuro”.
L’eco della Laudato si’ e il progetto dei fichi
L’intero territorio in provincia di Matera è caratterizzato dalla campagna del Metapontino. Siamo in una terra estremamente fertile dove si producono agrumi, fragole, eccellenza del ‘Made in Italy’, vino, pesche, fichi, albicocche e anche ortaggi, dunque una zona prevalentemente a trazione agricola. “Non è difficile in questo luogo guardarsi intorno e scorgere la mano di Dio, del Creatore - sostiene don Antonio - perciò possiamo dire che noi nasciamo già dentro la Laudato si’! Abbiamo un giardino da custodire e lo facciamo promuovendo un tipo di agricoltura sostenibile, biologica, non invasiva, che non sfrutta il suolo, ma lo valorizza. Il nostro compito è custodire questo luogo attraverso un’agricoltura rispettosa dell’ambiente ma anche delle persone, perché dobbiamo capire che non siamo disgiunti. Poi con i nostri progetti di reinserimento lavorativo e di lotta al caporalato contempliamo anche il recupero di terreni incolti, abbandonati che senza il nostro intervento potrebbero diventare discariche, luoghi altamente inquinati o peggio finire nelle mani della criminalità organizzata e utilizzati chissà in che modo. Il progetto relativo alla coltivazione dei fichi, nato grazie ad una rete di imprenditori, comuni cittadini e migranti, e a persone che hanno messo in comodato d’uso un terreno, creando di fatto una cooperativa, ci sta dando grande soddisfazione: i nostri ragazzi diventano esperti coltivatori capaci di relazionarsi alla terra con rispetto, perché in fondo da quella stessa terra vengono salvati e riscattati. Non è un progetto di tipo assistenziale ma favorisce l’autonomia dei soggetti coinvolti, così seguendo le parole del Papa noi favoriamo un’economia equa, giusta, solidale, che non inquina e che ridà vita. Produciamo anche il vino. In occasione del 27esimo Congresso Eucaristico a Matera, lo abbiamo donato al Santo Padre, che lo ha usato per celebrare la Messa, e a tutti i sacerdoti. Frutto della terra e del nostro lavoro, mi piace definirlo così: è un vino particolare, ancora più santo, perché dentro ci sono le ferite e il sogno di una vita degna di questi nostri fratelli migranti”.
Solidarietà e famiglia
Casa Betania e i vari progetti di inserimento lavorativo attraverso la coltivazione e l’agricoltura, rappresentano una svolta anche dal punto di vista culturale, in una terra come la Basilicata troppo spesso piagata da varie crisi. “E’ facile girare la testa dall’altra parte - esclama don Antonio -; è facile far finta di non vedere, ma invece noi sappiamo che è possibile costruire qualcosa di bello. Quando si fa il bene, questo per suo natura si diffonde. Non conta solo quello che offriamo a questi ragazzi, ma quanto poi ci restituiscono. Ogni giorno. Anche durante la pandemia hanno continuato a lavorare, ovviamente in modo regolare, nei campi. Vogliamo farli diventare protagonisti nel lavoro e, dunque, nella loro vita. Insieme alla diocesi, a Migrantes, al progetto ‘Liberi di partire, Liberi di restare’, stiamo creando diversi campi, dove unire lavoro, formazione e quindi integrazione. Oltre ai volontari, alla Caritas locale, agli operatori, la cosa più bella che posso testimoniare è la solidarietà di molte famiglie della parrocchia. Sono le cosiddette ‘famiglie tutor’ che prendono in carico alcuni di loro ma soprattutto se ne prendono cura. E’ quasi un’adozione, anche se i ragazzi non vivono a casa loro, però se ne occupano e preoccupano come se fossero dei parenti appunto e la domenica pranzano sempre insieme. Questa solidarietà, di cui parla anche il Papa nella Laudato si’ è fondamentale perché noi non prendiamo alcuna sovvenzione statale. Accoglienza e integrazione sono le cifre del nostro progetto che senza la terra, il lavoro della terra, non sarebbe possibile concretizzare”.
La testimonianza di Muda
Mohammed Souleiman, per tutti Muda, è stato il primo ad aver varcato la soglia di Casa Betania. Oggi è responsabile dei tanti uomini che, grazie a questo progetto, ritrovano fiducia nel futuro. La sua storia allora è un esempio per chi pensa di non potercela fare, di non essere in grado di uscire dalla rete dello sfruttamento e della criminalità dove anche lui, arrivato in Italia dalla Libia, era caduto. Prima di rialzarsi. “Sono arrivato in Italia durante la guerra in Libia, nel 2011 - racconta - Non avevo il desiderio di lasciare il mio Paese, ma sono stato costretto a farlo per la guerra assurda che era scoppiata. Ho attraversato il Mediterraneo, una situazione terribile, non si può immaginare. Eravamo migliaia, alcuni morivano, altri si salvavano. Io mi sono trovato sulla terra. Qui in Italia ho avuto difficoltà per la lingua, il lavoro. Sono andato a lavorare in campagna, ero sfruttato. Dormivo all’aperto, mi ritrovavo a guardare il cielo, avevo perso tutto quello che avevo prima. Sono stato a Foggia, non avevo un lavoro degno, non vedevo un futuro. Sono arrivato poi a Metaponto, al campo ‘La Felandina’, assieme a centinaia di persone come me. Circa ottocento. Per fortuna ho incontrato don Antonio Polidoro, che veniva lì per darci un sostegno. Non l’ho conosciuto dentro la Chiesa, ma sul campo. Ci portava cibo, vestiti. Poi è iniziato il percorso, vari incontri. Quando ci fu la tragedia della ragazza nigeriana, morta nell’incendio del campo (Petty, agosto 2019 n.d.r.), arrivarono tante associazioni, le forze dell'ordine. Tra le persone giunte in nostro soccorso c’era anche don Antonio e sono stato il primo ad entrare a Casa Betania. Oggi gestisco io questa realtà insieme a lui. La mia vita è cambiata al 100%, prima ho conosciuto sulla pelle cos'è lo sfruttamento, lo stare senza casa, senza amici. Oggi vivo qua con i miei fratelli, Casa Betania ci ha dato un tetto, è una risposta concreta allo sfruttamento lavorativo. Senza un tetto non si può vivere, senza una doccia, una cucina, senza poter mangiare. Questo è il cambiamento, senza una casa non c'è una vita. Quando parlo non dimentico mai che ho incontrato don Antonio sul campo, correva verso di noi per salvare le persone. Quella è stata una scintilla per la mia anima, anche io posso intraprendere la sua strada e aiutare gli altri! Anch’io vado sul campo a cercare i miei fratelli, a dare loro un sostegno. Ho capito il messaggio di don Antonio, ho imparato da lui e sto prendendo tutto questo sul serio. Altre persone possono avere ciò che io ho ricevuto, ci vuole coraggio per affrontare il caporalato”.
Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo a iscriverti alla newsletter cliccando qui